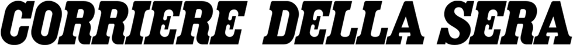LA VITA E' UN PALLONE - seconda puntata
di Marco Celati - Martedì 01 Novembre 2016 ore 10:00

Romanzo breve in cinque puntate
Mi iscrissi al liceo, eravamo grandi, smisi di giocare a calcio. Al professore di educazione fisica mancava uno per la corsa campestre e scelse me. Ero il prescelto: che culo! La pista di atletica al tempo non c'era. Ci allenavamo sugli argini dell'Era e dell'Arno e intorno al vecchio stadio Marconcini che, successivamente, il solito Sindaco spostò verso la zona del nuovo Stadio: una fissazione! Correre correvo, ma a me piaceva il salto in lungo. Avevo visto i saltatori neri americani fare quei gran balzi, scalciando e avvitandosi nell'aria. Volevo imitarli. Tutte le volte che il prof si distraeva andavo nella buca del salto in lungo e provavo il salto, sulla sabbia, dietro la porta. Allora il professore, non prima di avere richiamato la mia appartenenza al "settimo carciofi da campagna", mi dava da scrivere cinquemila volte "non devo entrare nella buca del salto in lungo, non devo entrare nella buca del salto in lungo..." Era questa la punizione che usava impartire agli indisciplinati come me. Mettevo cinque penne in fila, legate con il nastro adesivo, per fare prima, ma alla fine mi arresi e così l'Italia perse un potenziale saltatore. Tutta colpa dell'autoritarismo scolastico. Il fatto è che Marco Rossi era più bravo e faceva anche meno scena di me. Con un balzo solo e senza scalciare tanto per aria, mi superava. Ma lo stile era ordinario e si capiva che non avrebbe fatto tanta strada in atletica. Infatti da grande fece il medico. Un bravo medico. Recita anche in un gruppo teatrale amatoriale come "attor giovine" perché fisicamente è rimasto com'era. Probabilmente ha fatto un patto con il diavolo: da qualche parte in soffitta ha un ritratto che invecchia al posto suo. Magari il mio.
Vennero le campestri a San Rossore e le gare di mezzo fondo in pista, al Campo Scuola del CONI o all'Arena Garibaldi. Vincevo le gare di selezione per la mia scuola, anche contro quelli più grandi di me. Forse ero nato più veloce di quanto credessi. A Pisa, alle gare provinciali, ho vinto qualche batteria, ma poi in finale al massimo sono arrivato quinto ad una corsa campestre. È pur vero che eravamo un centinaio di ragazzi. C'erano atleti più preparati. Gli studenti delle scuole pisane facevano gioco di squadra. Lanciavano le "lepri" che si sacrificavano e poi i "campioni" uscivano dopo e ci staccavano. Erano scatti continui che mi spezzavano le gambe, parte del percorso era sulla sabbia. I pisani avevano la pista, gli impianti sportivi ed erano più allenati. E così, stante l'inadeguatezza delle strutture sportive e scolastiche pontederesi del tempo, l'atletica non fece emergere il corridore che potevo diventare. Del maratoneta avrei condiviso anche l'indole alla solitudine. Per la verità avevo resistenza, un po' di fiato, gambe robuste, ma non agilità di corsa, né senso della strategia di gara. Un anno, in pista, sbagliai i conti e scattai un giro prima dell'arrivo, facendo corsa isolata di testa per essere ripreso e, tra le grida del professore, superato sul rettilineo finale. Come Bitossi ai campionati mondiali di ciclismo. L'anno dopo, in compenso, tardai il rush all'arrivo e finii per un soffio fuori della finale. Vinsi agilmente la finale dei secondi, ma era quella dei secondi. Avevo sopratutto poca fiducia in me stesso. Anziché sondare le mie eventuali potenzialità, preferivo rifugiarmi nella coscienza sicura del limite.
Comunque le corse di fondo rafforzarono la mia determinazione e sentirmi veloce mi dette una nuova consapevolezza. E quando al mitico Bar La Posta misero su addirittura due squadre, tanta era la fauna maschile che lo frequentava, l'A.C. Mézzi e l'U.S. Sonati, mi offrii sul mercato calcistico come attaccante. Lo stemma dei Mézzi era un fiasco e quello dei Sonati, una campana. Le prime maglie furono improvvisate, bianche e bianco nere, ma poi, per la selezione rappresentativa del Bar, ci dotammo di una tenuta ufficiale. L'acquistammo sul Mercato dal padre di un giocatore che faceva l'ambulante. Era una maglia rossa, di quelle col taschino, di lanina. Andava bene per l'inverno, meglio per la mezza stagione, d'estate faceva un po' caldo. Il Bar, sul Corso, sotto il Comune, aveva fama sinistra, era abbonato anche a "L'Unità", ma ci giocava gente di tutti i colori politici e, i più, di nessuna fede. Nella custodia della carta d'identità, che esibivo all'arbitro, avevo messo anche la foto di "Cavallo Pazzo", il capo indiano. Voleva dire: corro veloce, sono alternativo e sono anche un po' scemo.
Che squadrone! C'era Polvere, "polvere di stelle", il portiere spazza aree, quando gridava «mia!» nelle uscite irruenti faceva un polverone, da qui il soprannome. Poi si alternarono in porta il Moscardini e il giovane Panaiotti, suo fratello Paolino, era un attaccante agile e scaltro. Il capitano era il Pappa, centrocampista e regista superbo. «Il Pappa non sbaglia mai» diceva. Io invece sbagliavo spesso il passaggio e lui s'incazzava: una volta si rotolò per terra dalla rabbia. C'erano Alioscia, figlio di Pinolo, padrone del Bar, difensore grintoso, Caffè, terzino di fascia, il Moro, mediano di spinta, Filippo, robusto libero dai piedi buoni. Il Mignudi, altra mezz'ala, Rivera, centravanti. Il Balico, attaccante di Forderponte. Totò, ala sinistra, che si ruppe un braccio al Brunner di Forcoli, il campo dove spesso si giocava. Il Lupazzo, attaccante compatto. Gocciola, fantasioso sul terreno di gioco, non meno che nella vita: inventore della "realtà aumentata", prima ancora dell'era digitale. Poi l'ispirato Draghetto e l'ottimo e puntiglioso Pelo, il cui soprannome descriveva un'evidente caratteristica fisica: aveva una diffusa peluria scura, perfino sulle spalle e, in compenso, un'incipiente calvizie. Il dialettico Bonsi e il ruvido Zizzi, un fisico da falegname: d'inverno girava solo con una maglia. Il Mézzo: un nome, un programma, generoso in campo e al banco del bar. Il Mézzotto, suo emulo. La Pera con il Mago e siamo nel mito.
Allenatore e arbitro d'occasione era Duccio d'Osimo, meditava di scrivere un libro che, purtroppo, è rimasto incompiuto per sempre: "Il calcio come scienza esatta". E poi Silvio, jolly in difesa, che merita una menzione speciale. Il Pappa gli diceva: «prendi l'omo, quanti passi fa lui, te fanne altrettanti!» E Duccio: «semmai portagli via il pallone con la terza gamba!» La difesa a zona a noi ci faceva una sega. A fine partita Silvio, accaldato e "rosso come un pipi di 'ane", andava a rapporto, con la sua voce stridula: «Pappa, i passi l'ho raddoppiati!» La terza gamba forse richiede una spiegazione. Il Silviati era secchino e minuto, ma aveva un pene fuori del normale, un fava "over size" insomma, che "gli rivava a' ginocchi". Nessuno ci voleva fare la doccia insieme. Il Lupazzo diceva: «se per caso ti 'asca la saponetta e t'accucci a raccattalla, capace gli va tutto il sangue all'uccello e 'un si sa come gli piglia!» Grande Silvio. Infine la Wehrmacht, soprannominato così a causa della sua passione per i modellini di aerei, carrarmati e altre macchine da guerra: era l'accompagnatore non giocatore e il caricaturista ufficiale della squadra. Ma ce n'erano altri: una panchina lunga, una leva calcistica. Diversi, oggi, sono stimati e compassati professionisti. Li ho ricordati così, in maniera confusa, come sono risaliti alla memoria, dopo tanti anni. A volte mi sembra di rivederli ancora nello spogliatoio o seduti ai tavoli, alla Posta, mezzo secolo fa. Di qualcuno non rammento più nulla. Nel Bar, Alioscia conserva una scatola con tutte le nostre foto, sempre più sbiadite e ingiallite dal tempo. Qualche volta si guardano, si fa l'inventario dei ricordi e la conta dei vivi.
Continua
Pontedera, 17 Ottobre 2016
Marco Celati