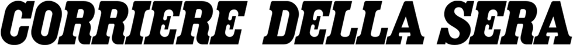LA VITA È UN PALLONE Romanzo breve in 5 puntate
di Marco Celati - Mercoledì 26 Ottobre 2016 ore 07:00

Prima puntata
Tornammo di casa al Villaggio. Il babbo lavorava alla Piaggio. Da operaio diventò impiegato di terza, diceva così, aveva frequentato l'avviamento al lavoro, era disegnatore. Abitavamo nel palazzo degli impiegati, un po' distante da quello degli ingegneri. Più in là c'erano le case degli operai, la Chiesa, l'Asilo, lo spaccio, i lavatoi. A parte l'insediamento classista, il villaggio di fabbrica come concezione urbanistica era avanti per il tempo. C'erano anche l'Enalino e l'Enal per i giochi dei figli e lo svago dei dipendenti. Era un altro mondo, un altro tempo, una città separata dalla città con le sue regole. C'erano spazi verdi intorno alle case, anche prati, non solo aiuole, ma il guardiano, c'era un guardiano, non ci lasciava giocare a pallone. Se ci sorprendeva a farlo ci prendeva la palla e ce la forava con un coltello. Fra le case non si poteva giocare. Per il calcio c'era il campo sportivo Piaggio, con tanto di tribuna coperta e i campi di basket, di pattinaggio e di tennis in terra rossa. C'era anche la squadra del Villaggio. Ma, sia il campo che la squadra, erano per i più grandi ed i bravi. Noi non eravamo né grandi né bravi e così giocavamo poco e a rischio della palla, delle rincorse del guardiano e dei rimproveri, quando andava bene, dei nostri genitori.
Fu questa ingiusta restrizione sociale del capitalismo che, reprimendo le mie potenzialità, m'impedì di diventare un giocatore di pallone. Se no chissà chi sarei stato nel mondo del calcio e anche questo racconto sarebbe stato tutta un'altra storia.
Oggi il campo del Villaggio Piaggio non esiste più. Crescendo la città e anche lo stabilimento, un Sindaco c'ha fatto fare un parcheggio per i lavoratori e gli impianti sportivi sono stati spostati più in là. Ma quel Sindaco che ne sapeva del campo del Villaggio? Capace a pallone non c'aveva mai giocato.
Quando avevo dieci anni ci trasferimmo alla Bellaria. Allora era quasi ancora campagna: oltre le abitazioni c'erano i campi coltivati e un sentiero sterrato che conduceva i più ardimentosi di noi alle fattorie del Beccani e del Tognoni e sull'argine dell'Era.
Dietro casa c'era un campo abbandonato che aspettava il suo destino, in quei tempi di boom edilizio. Lo eleggemmo a campo sportivo del quartiere. Tirammo su due pali e ci giocavamo dal pomeriggio alla sera. Nei giorni di festa, dopo la messa e d'estate anche al mattino. Era a gobba d'asino e, a furia di correrci sopra, ormai privo d'erba nel parte centrale. In compenso ai lati c'erano delle ceppe dove in diversi s'è perso palla e caviglie. Era il nostro campo. Lì ho imparato. E, se sapevi giocare lì, quando andavi sui campi di calcio veri ti stupivi di come era facile portare avanti la palla su un terreno bello pari. Tutti capaci così! Per la verità c'era anche un campetto di calcio, di fianco alla Chiesa dei Cappuccini, ma anche quello era per i grandi e i bravi. E io un po' più grande ero diventato, ma un po' più bravo no. E questa volta per colpa di nessuno.
In futuro il quartiere crebbe e nuovi impianti sportivi furono realizzati. Sorse la società "Bellaria Cappuccini" ad opera di padre Aureliano e "padre" Piero Becattini che frate non era, ma quasi. Ha dedicato la vita alla società. Poi un Sindaco spostò tutti gli impianti più in avanti, a ridosso dell'argine dell'Era, per far posto al quartiere. Era il solito che aveva spostato il campo del Villaggio. Doveva essere un vizio.
Alla Bellaria nel '60 incontrai bambini più forti: il Cappelli, più grande di età, un gigante buono, così lo vedevo, che era il capo indiscusso. Giovanni, il mio amico. Il Giovacchini che da giovane somigliò a Berlinguer e poi si fece prete. Nicola, altro amico d'infanzia e il suo nervoso fratello minore, Andrea, più piccolo, ma più bravo al gioco. Nicola che morì giovane di una brutta malattia. C'era il Caponi, figlio del macellaio, che giocava di fino, elegantissimo nei movimenti, scartava tutti, e poi tornava indietro e provava a scartarti di nuovo. Questo gli piaceva. Non fare goal. Finiva che si scartava da sé o alla fine prendeva una botta e, siccome aveva paura dei contrasti, la palla la perdeva. D'altra parte la regola tra noi rudi maschi pallonari era che se esageravi e facevi tanto il ganzo, una pedata te la beccavi e la portavi a casa. E poi c'era il Bianchi che aveva una finta speciale: un gioco rapido di gambe, destro sinistro, il pallone passava veloce da un piede all'altro e ti lasciava lì come un fesso. Non c'era verso, caracollava alla Garrincha e, o da destra o da sinistra, ti andava sempre via. Non riuscivo mai a fermarlo. Solo una volta. Tirai secco su una gamba: la palla no, ma la gamba la presi piena. Rimase dolorante a terra dicendo ad alta voce ogni bene di me e della mia santissima madre, in pace sia. Fortuna per me e purtroppo per lui, il Bianchi non era grosso, "Bianchino" infatti si chiamava, e, fra noi, arbitri non ce n'era. La prima volta che giocai con un arbitro rimasi colpito da quante regole c'erano nel gioco del calcio, a partire dal fuorigioco e non solo. Colpito ed anche ammonito.
Un giorno, toccò anche al nostro campo. Arrivarono le ruspe, spianarono, misero recinzioni. Ci facemmo un'ultima partita. Portammo dei fiori e li spargemmo tutt'intorno. Gli si dette l'addio così, per sempre: al campo e forse anche alla nostra infanzia. Una casa sorse al posto del luogo prediletto dei nostri giochi. Su quel campo ho giocato da bambino, in quella casa da uomo, nel corso della vita, ho anche abitato. Ci tornai, fresco di nozze, con mia moglie.
Crescendo, divenimmo ragazzi. Si andava fino all'Oratorio, in centro. Giocavo nella squadra degli Aspiranti contro quella dei Boy Scout. In genere, specie con l'inserimento del gruppo della Bellaria, si vinceva noi. Loro erano più bravi a fare i nodi. Dato che ero fra i più scarsi, mi misero in difesa. Allora funzionava così e chi proprio non sapeva si metteva in porta. Siccome ero destro, terzino destro. L'attacco era per i migliori, il centro campo per gli eccelsi, quelli che sapevano davvero, avevano controllo di palla e visione di gioco. Il mito assoluto era Rivera. Io ci vedevo poco, "quattrocchi" mi chiamavano per via degli occhiali, che, però, quando giocavo mi toglievo. Palleggiavo male e le poche volte che toccavo boccia, ridarla a qualcun altro mi rompeva i coglioni. E così, conquistata la palla, perché se la passavano solo fra loro bravi, accidenti alle su' mamme, m'incaponivo e andavo diritto a testa bassa, da solo. Fatalmente m'infrangevo contro la difesa per la mia frustrazione e la disapprovazione dei compagni di squadra. Uno scarpone. "Torna indietro, prendi il tu' omo!". Ma in difesa non mi garbava. Che palle! Dipendere dal gioco di un altro, dalle sue finte, a cui, oltretutto, quasi sempre abboccavo, sbagliando i tempi di entrata. Infatti o l'attaccante mi andava via o facevo fallo per la disperazione dell'allenatore. La soddisfazione invece era tirare in porta, fare un goal, gonfiare la rete. Per questo si esultava e si abbracciavano i compagni e l'eroe che aveva segnato. Per questo si giocava. E così, ogni volta che potevo, lasciavo la difesa e andavo in attacco, ci pensassero gli altri a badarmi, a prendere me. Come attaccante, però, non ero granché, in compenso come difensore ero del tutto inaffidabile. Eppure avevo imparato a palleggiare, toccando anche di tacco e, quando si giocava a palla a un balzo davanti la Chiesa dei Frati, gli davo di "giorgina". Si diceva così, chissà perché. Per prendermi in giro mi chiamavano "Tacchino". Ero talmente infervorato che persi il giubbotto nuovo che la mamma mi aveva appena comprato e che mi ero levato, appoggiandolo al muretto di una casa, per giocare a passaggi per strada. Di macchine allora ne passava poche. A sera tornai a casa e lo lasciai lì. Andai a cercarlo solo il giorno dopo, quando mi rinvenni. Ce ne trovai due. Era un giubbotto marrone di pilorre, sembrava di camoscio, mi dispiacque tanto. Alla mamma di più. Ho sempre perso di tutto negli spogliatoi e tante cose nel corso della vita.
Continua
Pontedera, 17 Ottobre 2016
Marco Celati